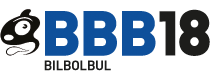Emelie Östergren. La sostanza
di Ilaria Tontardini
I virgolettati sono estratti da un’intervista a Emelie Östergren.
Questo articolo fa parte di BBB18 In corso d’opera, la guida a BilBOlbul 2018, in vendita all’infopoint e al bookshop nei giorni del festival.




Quando si incontra il lavoro di Emelie Östergren si è pervasi da una serie di sensazioni contrastanti. C’è un mondo d’infanzia che viene messo in scena; c’è un mondo di adulti che con questa si relaziona; ci sono interni gozzaniani e asfittici invasi da racemi di carte da parati sensuali e minacciose; ci sono buchi continui nella realtà; ci sono boschi lussuriosi in cui vegetazione, pietre, flutti e corpi sembrano modellati da uno stesso impasto gommoso e malleabile.
Proprio dall’‘impasto delle immagini si può iniziare ad addentrarsi nell’opera di Emelie Östergren, e dalla sua penna a sfera che, scivolando senza interruzioni, conferisce al disegno un movimento tortile e spiraliforme.
Östergren nasce in Svezia nel 1982 e dopo studi di illustrazione presso il Konstfack di Stoccolma, inizia a lavorare con il linguaggio sequenziale, passando con fluidità da storie brevi, strip (autoprodotte o pubblicate da Sanatorium Press, Kûs, Optimal Press) a fumetti più lunghi e albi illustrati (con Alfabeta, Lilla Pirat…) in un dialogo serrato e pieno di eco fra illustrazione e fumetto.
Un tratto stilistico e poetico distintivo si manifesta subito: una sensazione di “organico” della materia visiva con cui plasma ciò che rappresenta e che conferisce alle pagine la solidità di un universo. Nei disegni di Östergren tutto sembra pulsante, perfino i sassi; anche quando non accade nulla, pare che gli oggetti possano muoversi, che i tronchi morti possano iniziare ad allungarsi, che l’acqua sia solida e molliccia, che le stoffe siano della stessa carne delle foglie di ninfee o di alcuni bizzarri fiori esotici.
Da una parte, quest’aspetto organico delle cose rimanda all’infanzia e al suo sguardo, per cui tutto, anche ciò che è inanimato, ha una concretezza vitale e spirituale e non ci sono confini fra bambino, natura e “cultura”.
“Per me l’inizio dell’infanzia è il momento in cui sei veramente, veramente innocente. Uno spazio in cui si deve cominciare a imparare tutto dal principio e non si ha molta scelta su come iniziare a farlo. L’intera personalità prende forma. Si è giusto arrivati in un posto che qualcun altro ha desiderato per te, che sia un bene o un male. C’è qualcosa di epico in questo, tragico ma anche pieno di speranza; questi due aspetti assieme mi interessano. Sperimentare cosa sia capire la vita, senza avere nessun tipo di riferimento. L’infanzia è molto complessa, sebbene la facciamo sembrare facile e allegra.”
L’incontro, quindi, con ciò che circonda l’infanzia avviene in una dimensione simbiotica, in cui tutto ha vita: vivi sono i giocattoli che spesso costellano le rappresentazioni infantili di Östergren, vivissimi sono gli animali (come i maiali di The Pig) i mostri, le piante, i fiori, le pietre, queste ultime anche parlanti. Spesso nelle illustrazioni libere l’autrice crea accrocchi di questi elementi che si saldano insieme quasi formando dei monolitici blocchi pulsanti.
Per infanzia si intende non solo quella propriamente detta; personaggio ricorrente e emblematico in questo senso è il mostro mangia-pietre, una sorta di larva gigante con occhi e bocca spalancati caratterizzata da una ingordigia geologica senza spiegazione e senza giudizio. Come gli infanti, i mangia-pietre conoscono il mondo divorandolo, e crescono a vista d’occhio; nelle storie non rivestono ruoli narrativi funzionali, ma le attraversano come strane presenze sullo sfondo, come vigili e alter ego continui dei protagonisti. Dei bambini hanno anche la stessa natura sgraziata, acerba e intimamente (appunto) mostruosa.
Se esiste una peculiarità nella maniera interrogativa con cui Östergren rappresenta l’infanzia nei suoi libri per bambini – circa la metà della sua produzione –, è che questa assume un connotato di solitudine e di silente mistero quando si confronta con il mondo degli adulti. In opere come The Duke and His Army – A Dream Revisited (Sanatorium Press, 2011) – il viaggio di due donne bambine alla ricerca di una scatola dentro la scatola stessa –, e Little Boxes (Optima Press, 2012) – la misteriosa storia della scomparsa di alcune bambine dentro un collegio vittoriano invaso da una strana sostanza gelatinosa –, l’infanzia è vista come contenitore remoto in cui si conservano misteri che all’adulto non è dato più cogliere, e frazioni di innocenza che a contatto con la fragilità della realtà possono essere violate, contaminate e addirittura sparire.
In particolare, sono le figure femminili a rendere evidenti queste dinamiche. I passaggi dalla dimensione eterea dell’infanzia al corpo sensuale dell’adolescenza e poi alla decrepitezza dell’adulto sono i nodi in cui la società entra nel gioco fra gli individui.
“Questo passaggio – come il corpo diventa sessuato, come definiamo il nostro sesso e la nostra persona – mi interessa. Chi decide per noi? La pressione degli altri che ci indirizza verso un unico modello, anche se noi siamo tutti diversi; questo mi sembra comico, ironico ma anche strano. Molto del mio lavoro è cercare di ‘incarnare’ questa sensazione nelle textures che uso, nellle parole, nelle figure”.
La fisicità ancora una volta resta predominante e la deformazione agisce impietosa sulla carne, sulle espressioni, sulla definizione grottesca del femminile, ma soprattutto del maschile (trasformato in verme, ridicolizzato da impossibili mises militari come in The Duke and His Army – A Dream Revisited), escludendo ogni giudizio morale esplicito, lavorando invece sulle zone di ambiguità, sulle sottili dinamiche tra dominato e dominatore. Il mondo organico dell’infanzia diventa viscerale e molle e ci si cade dentro in continuazione in un movimento che è un ciclico precipitare nei recessi dell’inconscio (in cui ricorrono elementi simbolici come l’acqua, i capelli, gli alberi…) e un venire al mondo, una nascita o rinascita.
L’impasto del mondo di Östergren è pieno di buchi: crepe, crateri, tane che sembrano tombe, fessure, squarci fra le tende. La dimensione del passaggio caratterizza anche un’altra costante del lavoro dell’autrice, i sottili e resistentissimi fili di comunicazione fra il mondo reale e quello fantastico.
“ll fantastico è vicino a me e ai miei disegni; mi piace che le immagini possano spingersi molto più in là di ciò che ho pianificato. Quando disegno, questo è possibile. Penso che il mondo reale sia prossimo a molto altro, come qualcosa che vuoi dire ma che non è nelle parole, una specie di sensazione. Questo è ciò che mi attrae di più in un fantastico ‘discreto’. L’idea che si possa sollevare una foglia e che sotto si possa scoprire una vita che non si sospettava. Il fantastico è reale e per me è come una religione. Abbiamo bisogno di parti illogiche per non diventare pazzi… E non so perché noi umani tendiamo a rendere tutto il più logico possibile”.
Una volta aperto il varco i due mondi si fondono, se ne fondono le logiche, ed è impossibile distinguere l’uno dall’altro. Nelle storie della disegnatrice non si ripristina mai uno status quo: si sprofonda – moltissimo – si cambiano i mondi e i percorsi alternativi, ma è impossibile tornare al punto di partenza, una volta varcata la soglia.
Il fantastico per Östergren non è quindi parentesi, ma scivola e si intride di normalità: fuoriuscendo dai quadri come in Little Boxes, resistendo nelle profondità nascoste sotto i pavimenti come in Yellow Cloud, contaminando le dimensioni delle cose che, come in Alice nel paese delle meraviglie (opera che attraversa a molteplici livelli la produzione dell’autrice, da quelli prettamente iconografici ai motivi più fortemente narrativi) subiscono continue mutazioni. Lo squilibrio è integrato, il dubbio – dove vanno le cose che scompaiono continuamente? Cosa fanno i tanti personaggi che transitano nelle storie? – non esiste, ma se ne respira la sospensione in quei groviglio di rami, capelli, massi e foglie che invade le immagini.
Da due ‘modi’ del fantastico vengono due autori che l’autrice annovera fra i suoi maestri più importanti: l’illustratrice danese Ingrid Vang Nyman (1916-1959), nota soprattutto per aver dato il primo corpo disegnato a Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, e Edward Gorey (1925-2000).
Dalla prima mutua il gioco della nitidezza dei contorni, che definisce nello spazio della pagina i personaggi e tutte le cose che stanno loro attorno, quasi come se tutti gli elementi fossero fondamentali, come degli attributi di santi. Come lei anche Östergren non usa le ombre, creando un contrasto forte tra la luce raggelante e immutabile dentro le sue immagini e il peso dei corpi, che proprio per la loro gravità sembrerebbero dover proiettare poderose e minacciose ombre.
Di Gorey invece – oltre a una comune fascinazione per il mondo vittoriano, che si fa in entrambi marchio distintivo – riprende l’ironia inesorabile, una crudeltà sottile verso le proprie creature. Ma soprattutto goreyano è il senso di perturbante dato da presenze che non si vedono ma si sentono, dal gioco con i dettagli incongrui che proprio nello scivolare continuo dei piani del racconto fra reale e surreale, fra vero e più vero.
Così Emelie Östergren riesce a dare forma a sensazioni profonde, a volte oscure a volte semplicemente impossibili da dire, modellando la materia, plasmando – inconsapevolmente dice l’autrice, ma non del tutto – un disegno che alletta lo spettatore e lo intrappola poi come una pianta carnivora. Ghignando gentilmente mentre la bocca del fiore si chiude sulla vittima.