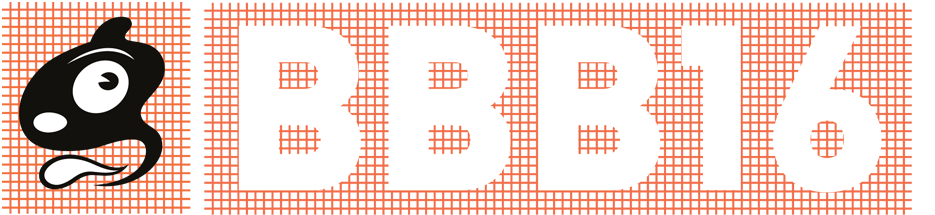Emmanuel Guibert, o la mistica dell’amicizia
 Estratto dall’intervista realizzata da Francesco Boille a Emmanuel Guibert, e pubblicata sul numero 117 (marzo 2010) de “Lo straniero“.
Estratto dall’intervista realizzata da Francesco Boille a Emmanuel Guibert, e pubblicata sul numero 117 (marzo 2010) de “Lo straniero“.
La trilogia de Il Fotografo incrocia reportage fotografico e fumetto. Ma per come si articola, in termini di scrittura, approccio grafico, ambizione, oltre che, ovviamente, per la qualità degli uomini che si sono dedicati alla sua creazione e di coloro che vi sono narrati, mi pare anche un grande viaggio interiore che si concretizza con uno slancio verso l’esterno, nel senso ampio del termine, vale a dire verso l’altro, la sua conoscenza…
Il Fotografo, è il racconto del primo reportage di un giovane uomo, Didier Lefèvre, molto ignorante della realtà che scopre, ma pieno di vita, di curiosità e di amore per il suo mestiere. Il racconto, di cui è il narratore, permette di scoprire alcuni aspetti dell’Afghanistan degli anni ’80, dei suoi popoli, dei medici che vi s’impegnano in piena guerra, ma anche molte caratteristiche della psicologia di Didier e degli avvenimenti che lo fanno soffrire. In questo senso, il viaggio “dal di dentro” e la realtà esterna sono indissociabili, ragione per la quale questo racconto si chiama appunto Il Fotografo, e non L’occupazione sovietica in Afghanistan o MSF tra i Moujaiddin.
Il caso dell’eroe dell’opera, appunto il fotografo Didier Lefèvre, pare anche l’emblema di una possibile unità, una fusione, tra la qualità degli uomini che raccontano e coloro che sono raccontati. Un ‘eroe’ che tale non è: ed è proprio per questo che, forse, lo diventa, per noi, i lettori…
Didier, Juliette, John, Régis, Robert, Sylvie, Évelyne, ecc… tutti rifiutano ovviamente il termine di ‘eroe’, che, al più, li fa ridere, al peggio, li irrita. Nondimeno, incarnano, ciascuno a loro modo, un tipo umano che crede nell’azione, al reciproco aiutarsi, all’amicizia, alla necessità vitale di riparare quel che è intaccato, e tutti hanno superato delle prove grazie ad una qualità che eccede anche il loro coraggio: il senso dell’umorismo. Fanno parte delle persone al mondo che amo di più, mi sento felice e fortunato di conoscerle. Questo libro è, anche, un tentativo di presentarli al lettore.
Trova che si possa parlare di un viaggio interiore all’interno del fumetto franco-belga? Quando Lefèvre dice, verso la fine del primo volume, che a tratti pensa a Tintin – Tintin in Tibet, nella fattispecie -, che Tintin è davvero una cosa forte e che spesso crediamo di esser passati da dove è passato, questo non sembra soltanto un omaggio ad un grande classico del fumetto che praticamente qualsiasi ragazzo della vostra generazione ha letto e riletto, ma anche una maniera, da un lato, di rimanere fedele al fatto che «nei grandi autori che ammiro, Hergé, Goscinny, Franquin, si risenta così tanto il lato diario intimo (intervista con Gilles Ciment, Neuvième Art n. 8, janvier 2003)», e, dall’altro, di confrontare questo immaginario eroico e dell’avventura, al reale, al dramma della guerra e delle sue sofferenze, tentando di essere altrettanto eroi nella vita adulta, quando l’avventura va mano nella mano con il dramma… Tutta la vostra opera pare un’interrogazione su come uscire dall’infanzia per divenire uomini compiuti pur mantenendo una parte d’infanzia: l’incanto, il senso dell’umorismo, la fedeltà agli amici…
Quando si è letto molti fumetti da bambino, come nel mio caso, si può evitare di pensarci quando si lavora. Sono occupato da una sola cosa quando faccio i miei libri: come veicolare della vita, delle emozioni, delle idee, con i mezzi del fumetto (anche a costo di aggregargli altri mezzi, come la fotografia, nel caso presente). Quando la storia è molto appassionante, come quella che Didier e la squadra dei medici mi hanno raccontato, bisogna mobilitare tutto il proprio savoir-faire per dargli la forma che si conviene. Amo questa responsabilità…
La questione della memoria pare importante nella vostra opera…
La memoria è il nostro organo più nascosto, il più misterioso, il più doloroso e il più erogeno assieme. Ed è la fonte di ogni creazione.